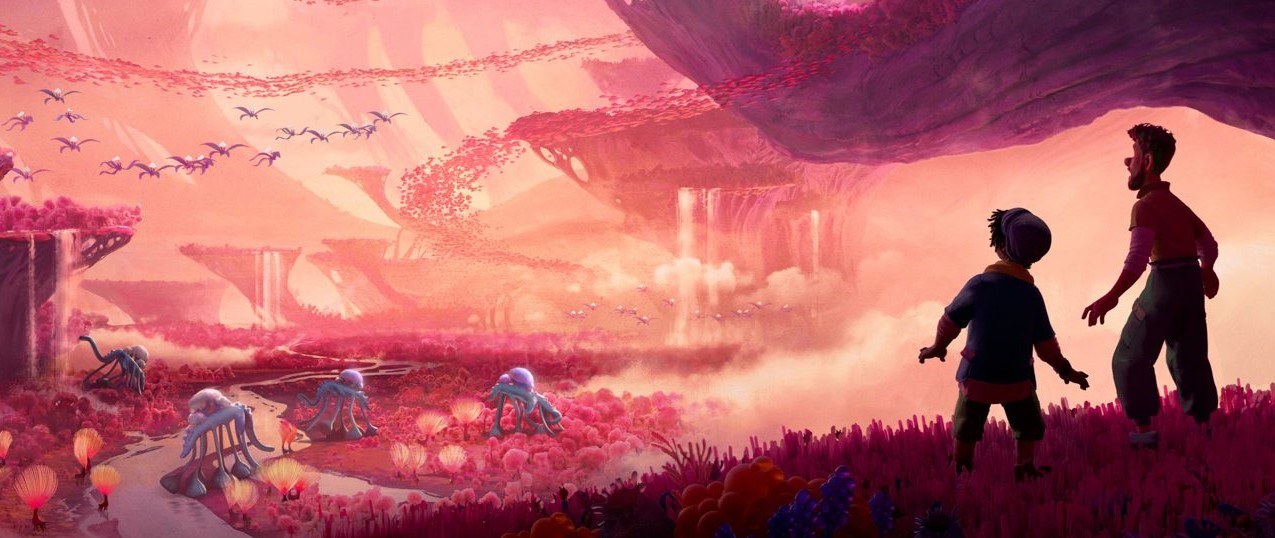Vi ricordate la pappardella sul morire da eroe o vivere abbastanza a lungo da diventare il cattivo? Ecco, è una cosa che tendo a veder succedere ciclicamente nel mondo delle arti mediatiche. I miti di ieri che prima sono intoccabili e poi diventano – nel percepito comune – i mostri di oggi. Colpa di tanti fattori, del cambiamento, soprattutto. Autori, artisti, studi e realtà produttive che magari in una certa fase storica trovano una certa sintonia con lo scenario culturale del momento. E poi magari evolvono male: incespiscano, esagerano, tradiscono le aspettative… e a volte nemmeno quello. Semplicemente non sono più una novità, e il pubblico molto banalmente ne è stanco. Ne mitizza la fase iniziale, la mette sopra un piedistallo e poi decide che da un certo punto in poi basta.
Di recente questo è successo allo Studio Ghibli. Vent’anni fa una primizia da cultori, il portabandiera acclamato di un altro modo di intendere il cinema d’animazione. L’alternativa orientale, la realtà autoriale a cui perdonare debolezze tecniche o narrative, sacrificando ogni critica sull’altare del relativismo culturale. La fortezza dietro cui mettersi al riparo dallo strapotere dell’animazione hollywoodiana. Ricordo tutto.
E ricordo anche la lenta ma graduale disaffezione delle masse. Quelli che perdevano interesse con lo scoprire che il logo di Totoro non celava solo Miyazaki ma anche altri autori magari meno mainstream o più ostici. Quelli che all’ennesimo adattamento cannarsiano rinunciavano e preferivano volgere lo sguardo verso altri orizzonti (Hosoda, Shinkai etc). Dello Studio Ghibli ci si è stufati, lo si è visto battere in ritirata e chiudere i battenti, salvo riapparire oggi dopo anni. Per la regia del discusso Goro Miyazaki. E in CGI. Uh.

“Earwig e la Strega” mi è piaciuto molto. Me lo sono proprio goduto, ma al leggerne le recensioni avrei dovuto odiarlo. Non è un film perfetto, ma penso che non lo sia nessuno del catalogo Ghibli, nemmeno gli irrinunciabili, nemmeno gli amatissimi. La critica l’ha stroncato, e a mio parere questo è successo perché la maggior parte dei recensori appartenevano a quel famoso momento culturale là, quello dell’Oscar alla Città Incantata e della mitizzazione di Hayao.
Cominciamo dalla grafica, che è stata un po’ la pietra dello scandalo. Graficamente parlando il film è molto ben fatto e la CGI usata non è economica. Anzi, la resa grafica di Bella Yaga, Mandragora e della madre di Erwig sono quanto di meglio il giappone abbia da offrire in questo campo. Il modello dei bambini con i loro tratti neutri non è riuscito quanto quello delle figure grottesche e mostruose, e ha margine di miglioramento, come del resto avviene spesso anche in occidente. Ma l’effetto straniamento penso che derivi semplicemente dal fatto che lo stile Ghibli è stato portato nella terza dimensione, e a questo non eravamo abituati. Non è stile WDAS, non è stile Pixar, è la versione volumetrica del chara design dei vari Howl e Ponyo. E, se proprio la vogliamo dire tutta, non è che ai tempi del 2D l’animazione Ghibli fosse perfetta: c’erano scatti e non tutto era fluido, data l’abitudine orientale di rifuggire la “full animation”. Paradossalmente il passaggio alla CGI ha invece fatto da livella, aumentando la fluidità e diminuendo lo scarto.
Narrativamente è uno dei Ghibli più originali e spassosi. La bambina protagonista non è una figura del tutto positiva, elemento di novità non da poco, e I “cattivi” con cui la vediamo interagire sono probabilmente fra I personaggi meglio riusciti dell’intero catalogo Ghibli. Quando Mandragora entra in scena, qualsiasi cosa dica o faccia monopolizza l’attenzione, e non è l’unico elemento decisamente ispirato. La storia rientra nella fascia di leggerezza a cui appartengono un sacco di altri film dello studio e come questi tende ad affastellare eventi ed episodi uno dietro l’altro. La pecca grossa sta nella mancanza di sviluppo della backstory: il film suggerisce che I personaggi abbiano un passato comune, mostra stralci e spezzoni di flashback, sembra voler puntare in quella direzione… ma poi sceglie di lasciare tutto all’immaginazione, chiudendo con una sorta di buffo cliffanger che sa più che altro di trollata. Cattiva scrittura? Scelta precisa? Bizzarria random? Erano finiti i soldi? Chissà. Certo è che a roba del genere i Miyazaki ci avevano già abituati in passato: cambi di focus, nuovi elementi introdotti nella narrazione in fase troppo avanzata, vicoli ciechi e risoluzioni alla bell’emmeglio (ricordate Howl?). Però boh, all’epoca non si poteva parlare di buchi, era solo un tipo di struttura slegata dal tradizionale, claustrofobico e formulaico meccanicismo narrativo occidentale.
Uhm.
Vabbé, in ogni caso una possibilità se la merita. Anche solo per provare l’ebbrezza di poter vedere un Ghibli in cui i personaggi parlano senza sembrare dislessici. Un bacio, Gualtiero.