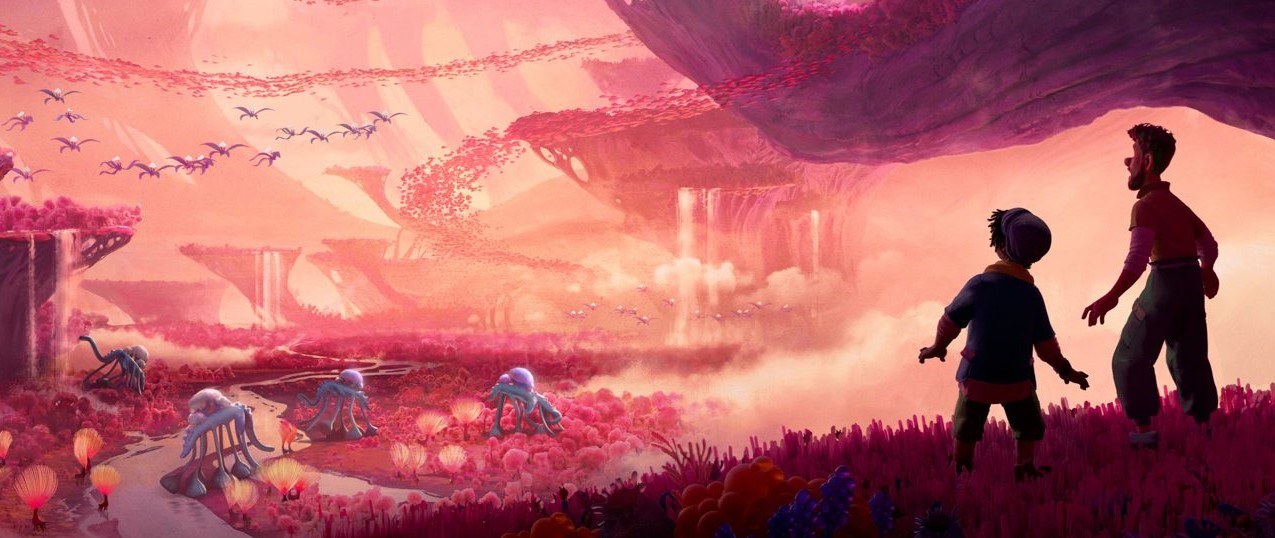Nel giro di soli otto episodi The Mandalorian ha conquistato proprio tutti, ma tutti tutti. Non era facile, specialmente se sei parte di un franchise chiamato Star Wars, e specialmente2 se hai il fegato di uscire a ridosso di Episodio IX, con tutto quello che una cosa del genere comporta. D’altra parte, forse è proprio la nube tossica che avvolge Star Wars ad aver spianato la strada al mandaloriano. Perché una delle cose più brutte in assoluto del fenomeno Star Wars è proprio la tendenza del pubblico a viverlo come se le sue singole parti fossero in opposizione fra loro. Pensiamoci: Originali vs Prequel, Prequel vs Sequel, Esalogia Lucas vs Trilogia Disney, Sequel vs Rogue One, J. J. Abrams vs Rian Johnson, Solo vs tutto e via dicendo. Brutta questa cosa, specialmente per una saga che punta ad una costruzione crossmediale armonica e totalmente interconnessa. Certo, un modo per prevenire questa frammentazione ideologica sarebbe stato evitare di assegnare la terza trilogia ad un regista che di Star Wars ne apprezza solo il 50%, ma ormai è andata. Adesso è il mandaloriano a tenere banco, e per molti appassionati “questa è la via”. Ma è la via? Siamo sicuri che davvero un prodotto come il mandaloriano avrebbe potuto fare le veci dei tre sequel, sostituendosi felicemente ad essi? Io non penso, rimane comunque una “sidestory”, un brillante approfondimento di un singolo aspetto di Star Wars, che non basterebbe mai a saziare gli appetiti di chi invece desidera tutto il pacchetto. Sotto un altro punto di vista però, il mandaloriano, distinguendosi per solidità, intelligenza, onestà e consapevolezza, ci mostra veramente “la via” per una gestione del brand più illuminata. Vediamo alcuni punti:
Tanto per cominciare The Mandalorian trasmette sicurezza. Mentre la trilogia sequel, col suo cercare di inseguire tutti, di dissimulare le sue traversie produttive, finisce invece per sottolinearle, sembrandoci un prodotto fondamentalmente molle, instabile e spaventato, la serie di Mando punta dritto all’obiettivo, senza farsi distrarre dal chiacchiericcio intorno a sé. In cabina di regia c’è gente quadrata, che conosce Star Wars, lo ama nella sua interezza e senza censure. E soprattutto sa che il miglior modo di lavorare è partire da un’idea narrativa precisa, non certo da spunti vaghi o da ricerche di mercato. E se parti da un’idea e hai le palle di raccontarla fino in fondo, la tua storia sarà quel che sarà (in questo caso nulla di originale: un cacciatore di taglie trova un bambino magico e si intenerisce) però risulterà credibile, sobria e, a suo modo, carismatica. Ed ecco che la gente abbasserà la guardia e si farà irretire, sospendendo per un po’ la caciara internettiana.
Baby Yoda. Non ci si crede, ma a sorpresa questi calano l’asso e creano un fenomeno di costume. Partendo da un concetto che lo stesso George Lucas rese tabù (la razza di Yoda), in un colpo solo l’idea dello Yodino si aggiudica l’attenzione del pubblico di appassionati, del pubblico mainstream e… di quello delle loro fidanzate. Sarebbe fin troppo scontato fare facile ironia sulla Disney pucciosa ma malefica che ti vende il pupazzo, se non fosse che qui c’è ben poco da deridere e molto a cui fare tanto di cappello. Perché questo ranocchietto capolavoro lo è veramente, una lezione di cinema coi controfiocchi. Nel dna di ogni singolo frame in cui appare scorrono decenni di storia dell’animazione e della puppetteria. Nei suoi silenzi, nei suoi sguardi, nei suoi micromovimenti un occhio esperto può trovarci principi artistici che risalgono a Norman Ferguson, a Jim Henson, a Frank Oz. All’occhio inesperto invece tutto questo arriverà comunque, sottoforma di espressività, di legame empatico, creando nel pubblico la giusta risposta emotiva. Hold my beer, Maz Kanata.
E poi abbiamo Dave Filoni che riesce a rendere commestibile il Nuovo Canone. Perché, dai, diciamolo: si ha un bel parlare di Star Wars come di un progetto interconnesso, crossmediale, completo di romanzi, fumetti e serie animate che hanno lo stesso peso dei film collegate tra loro come in un affresco organico. In linea teorica è ovviamente così, ma lo sanno i creativi, lo sa Dave Filoni, lo sanno gli appassionati più attenti e quelli con maggior prospettiva e visione d’insieme. Non lo sa il grande pubblico e anche all’interno del fandom c’è chi rifiuta questo concetto (e fra questi capace che ci sia anche J. J. Abrams). C’è un motivo se siamo arrivati a questo, ed è che il Canone di Star Wars è bellissimo ma scomodo. Quantomeno sul piano della fruizione. Nei romanzi è stato detto molto e ce ne sono di bellissimi (consiglio quelli di Claudia Grey!) ma il rapporto tra quantità di materiale e sua effettiva utilità non è buono. Lo stesso vale per le serie animate. In The Clone Wars e Rebels sono state scritte pagine importantissime della mitologia di Star Wars, pagine che un appassionato della Saga non dovrebbe poter ignorare a cuor leggero: Ahsoka, Mortis, Maul redivivo, il Mondo tra i Mondi, i Purrgill, Thrawn e ovviamente la storia di Mandalore. Le ha scritte Filoni, pupillo di Lucas, e una delle due grandi menti dietro a questa serie. E chi se le è viste? Pochi, pochissimi. Perché infilate in un formato “scomodo”, dispersivo, pensato per un altro target. Un tesoro che ad oggi è rimasto “nascosto”, a meno di non volerci investire del tempo. Ma con l’affermarsi di questo nuovo formato, le miniserie live action ad alto budget su Disney+, queste linee narrative possono trovare sviluppo e finalmente diffusione. C’è però da lavorare ancora un po’ sulla percezione da parte del pubblico. Ed ecco allora che Dave Filoni parte in punta di piedi, inserendo riferimenti sempre più corposi per poi esplodere in un cliffanger finale che sembra dire allo spettatore generalista “fila a recuperare ciò che ti sei perso”. Materiale che guarda caso è già stato caricato per benino in piattaforma, e che a febbraio verrà arricchito con la settima stagione di TCW “postuma”, incentrata – guarda caso – sull’assedio di Mandalore. C’è astuzia in questo, ed eleganza. E prospettiva, ovviamente.
Poi ci sarebbe altro da dire, molto altro. Si potrebbe parlare della carismatica Cara Dune di Gina Carano, di quell’immenso personaggio che è il Kuill di Nick Nolte, della tradizione western e del cinema di Kurosawa che viene a più riprese onorato, citato e “coccolato”. Si potrebbe parlare del fatto che questa prima serie Disney+ con il suo approccio cinematografico cancella definitivamente quello scarto qualitativo tra cinema e tv che prodotti come Lost avevano già cominciato a ridurre anni fa. O di come l’alternarsi di diversi registi agli episodi conferisca ad ognuno di essi un’impronta autoriale che però non confligge con il quadro d’insieme. Si potrebbero anche fare critiche: chi scrive non ha amato il sesto episodio, mentre altri si sono trovati disorientati quando, a partire dal quarto, la serie ha abbracciato una struttura più verticale. Ma tutto questo precipita nell’irrilevante se si pensa al vero “elefante nella stanza”: Nel 2015 JJ Abrams era stato aspramente criticato per aver “copiato” Episodio IV trapiantando nel suo Episodio VII concetti, estetica e ambientazioni dal film del 77. Oggi Filoni e Favreu mettono on screen una vicenda che vede come protagonisti le versioni tarocche di Boba Fett, Yoda e IG88 e ne escono alla grande diventando i salvatori della patria. Scroscianti applausi.